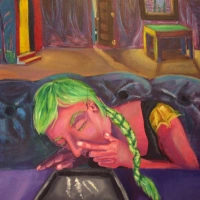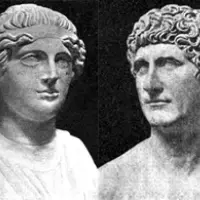Se il mare potesse dar voce ai propri pensieri avrebbe molto da raccontare. Il mare; l’ultima speranza per quanti – costretti a fuggire da luoghi di guerra e di morte – giungono sulle coste italiane (quando vi riescono!) confidando nella possibilità che qualcosa cambierà; che il civile, urbanizzato e pacifico Occidente li accoglierà a braccia aperte e consentirà loro di integrarsi, di svolgere la propria vita, di esplicare la propria personalità, di sentirsi graditi nella loro “nuova casa”.
Cedono la loro stessa dignità i migranti di oggi, in cambio di un sogno; lasciano la loro Terra e tutto quanto sono riusciti a conquistare con fatica e sacrificio, con lacrime amare, sangue, sudore, per saltare su un barcone, accattivati dal miraggio di un’oasi nel deserto.
Non si può decidere il luogo in cui nascere, purtroppo o per fortuna. Non lo scelgono i migranti di oggi, non lo scelsero i nostri avi uno o due secoli fa, quando – tra il 1820 ed il 1940 – con la valigia di cartone e i pochi risparmi di tutta una vita imboccarono la via del mare alla ricerca del riscatto sociale, quello che avrebbe permesso ai loro figli ed alle generazioni future di godere dei frutti del loro sacrificio. Scoprirono un mondo diverso da quello che conoscevano ed al quale erano abituati: l’America, il posto che avrebbe cambiato loro il futuro e le prospettive, la Terra dei miracoli, il luogo ove tutto è possibile e che consentì loro di trasformare i pochi spiccioli con cui erano partiti in grandi capitali. Che fosse per capacità imprenditoriale, fortuna o chissà cos’altro, questo poco importa.
Non è il colore della pelle, ma l’approccio a quel viaggio infinito in mezzo al mare che fa la differenza sostanziale tra i migranti della nostra epoca ed i nostri bisnonni; un viaggio di speranza per questi ultimi, l’ultima speranza per i primi.
Meschina agli occhi ed al cuore di chi vive una vita dignitosa dovrebbe risultare la convinzione perorata e spiattellata nei salotti televisivi di varietà e programmi di informazione secondo cui i nostri migranti sono stati uomini migliori di coloro che arrivano oggi attraverso il Mediterraneo a Lampedusa o sulle coste siciliane.
Non c’è differenza tra gli uni e gli altri se si attribuisce loro la peculiare qualità che dovrebbero avere: sono uomini, persone, individui; hanno diritto ad esser trattati come tali.
Ma veniamo ai fatti ed analizziamo il problema su cui da tempo ormai, anche in spregio a norme preconfezionate, si arrovella la politica internazionale. Accoglienza o respingimento; questo è il dilemma rispetto al quale non si riesce a trovare una soluzione equa. Da un lato gli accordi internazionali e le leggi, la necessità di regolare i flussi e smistare quanti arrivano in Italia tra centri di prima accoglienza, procedure di identificazione, attivazione degli iter di espulsione, richieste di asilo o protezione internazionale e tutto quanto la farraginosa burocrazia richiede; dall’altro le ragioni di umanità e di tutela dell’essere umano, quelle che impongono di buttare a terra qualche paletto perché la vita va salvaguardata a prescindere dalle procedure ed ogni caso va trattato in ragione delle particolarità che presenta.
Sono trascorsi pochi giorni da quello che – a detta delle organizzazioni umanitarie maggiormente rappresentative – può considerarsi il più grande respingimento della storia. Il 24 giugno 2018 un migliaio di migranti alla deriva su sette barconi sono stati riportati a terra dalla guardia costiera libica.
Mentre l’Italia con la sua nuova formazione politica tentava di intavolare trattative e siglare in seno al Consiglio europeo l’accordo per la gestione dei flussi migratori (missione portata a termine con esito positivo sulla carta), altre cento persone a bordo di un gommone sono morte al largo delle coste della Libia per aver atteso invano i soccorsi, per ore.
Ancor prima, al centro del dibattito politico c’è stato il caso Aquarius, la nave di soccorso della Ong SOS Mediterranée con 629 migranti a bordo bloccata per giorni in mare perché il neoeletto Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiuso i porti italiani ed impedito alla nave carica di “carne umana” di attraccare. A detta del Ministro l’Italia è sola nell’accollarsi un problema che invece toccherebbe sbrogliare all’Europa intera; era necessario lanciare un segnale forte e chiaro, non importa se a rimetterci il bene più prezioso erano più di seicento persone.
Solo l’intervento del governo spagnolo ha permesso di superare l’empasse e Aquarius è arrivata a Valencia il 17 giugno scorso, accompagnata da Orione, nave della Marina militare italiana, e da Dattilo, mezzo di trasporto in mare della Guardia costiera.
Ma di casi da raccontare ce ne sarebbero un’infinità, il problema è che dimentichiamo tanto in fretta quanto più intense sono le nostre lacrime davanti al televisore allo scorrere di immagini che denotano più che adeguatamente la (dis)umanità del mondo.
La nostra gestione del fenomeno la dice lunga su quanto poco abbiamo fatto tesoro delle esperienze del passato e su quanto poco conosciamo la storia dell’umanità.
Conosci il passato e comprenderai il presente. Forse il problema è proprio questo, non conosciamo la storia; difettano in noi i rudimenti più basilari dell’antropologia; ignoriamo, probabilmente, che l’uomo è nato nomade e ciò ha consentito che dall’Africa si costituissero comunità in molti altri luoghi del pianeta. Ciò ha garantito la conservazione della specie.
Ebbene sì, a tutti coloro che guardano al fenomeno dei migranti come ad un problema (lo è senz’altro se lo si considera nei termini esatti che dovrebbero darsi alla questione, ma ciò presupporrebbe che si incominci a cercare concretamente una soluzione adeguata a fronteggiare le emergenze n.d.r.), quel che si vuole ricordare è che se oggi siamo qui e viviamo la vita dignitosa e comoda che ci è toccata, in fondo è solo merito dello spirito ramingo dei nostri antenati.
Immagine di copertina
Categorie:ATTUALITÀ