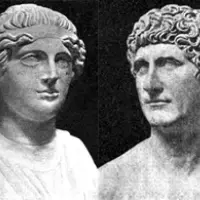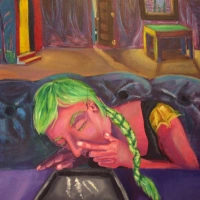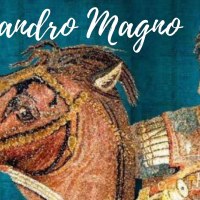Presentato in concorso nella sezione ‘Venezia Classici Documentari’ alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è uscito quest’anno “Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e Cinema di Claudio Caligari”, diretto dai registi Fausto Isola e Simone Trombetta.
Il docu-film è un corale e viscerale omaggio, attraverso interviste e filmati d’epoca, al regista piemontese Claudio Caligari, prematuramente scomparso nel 2015.
Relegato ingiustamente ai margini dell’industria cinematografica, la potenza autoriale di Caligari sta finalmente librandosi oltre i circuiti di nicchia per ricevere le attenzioni a lui dovute da un pubblico più vasto in grado, adesso, di poter apprezzare e rimpiangere un regista sempre coerente con le proprie idee di cinema e vita, geloso delle proprie convinzioni e intransigente anche con se stesso, soprattutto ostinatamente determinato a realizzare i suoi film in nome di un’urgenza creativa che fino alla fine l’ha reso, al di là delle personali delusioni e taciuti dolori, un battitore libero.
Affinché l’eredità di Caligari non vada perduta, il documentario ripercorre la lavorazione dei suoi tre film, “Amore Tossico“, “L’odore della notte” e “Non essere cattivo“, pellicole che come poche altre nella Storia del Cinema nostrano, sono state capaci di raccontare quelle vite rotte che scorrono lungo i bordi.
Questa è la nostra intervista al poeta e polistrumentista Marco de Annuntiis, non solo ideatore e compositore del documentario “Se c’è un aldilà sono fottuto – Vita e Cinema di Claudio Caligari“, ma anche artista che, come Caligari, ha deciso di essere un cantore della strada, senza pietismi né commiserazione.
Da dov’è nata l’idea di realizzare un docu-film sul compianto regista underground Claudio Caligari?
Nella vita faccio il cantautore e anche questo progetto nasce con una canzone alle spalle: il primo giorno di riprese di “Non essere cattivo” mi presentai sul set perché desideravo conoscere Caligari e consegnargli una prima registrazione del “Blues della Renault” (il brano che ora è sui titoli di coda di “Se c’è un aldilà sono fottuto”) chiamata così proprio perché avevo notato che in “Amore tossico” tutte le auto usate da Cesare nel film erano modelli Renault dell’epoca. Poi verso la fine delle riprese arrivò la scena in cui sparano a Luca Marinelli, e Claudio manda anche questo “nuovo Cesare” a fare una rapina su una Renault, stavolta una Renault 5 degli anni ’90: mi sembrò enorme come coincidenza e ho subito pensato che Claudio avesse voluto inserire un’ulteriore auto-citazione, a volte amo pensare addirittura che forse avesse scelto una Renault proprio per raccogliere il mio suggerimento. Non lo saprò mai perché quella fu anche l’ultima volta che lo vidi, sarebbe morto poche settimane dopo. Probabilmente la voglia di realizzare un lavoro che gli rendesse omaggio nasce proprio dal rimpianto di non aver avuto tempo e modo di conoscerlo meglio come avrei voluto.

Il suo rapporto professionale e amicale con uno dei due registi di “Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e Cinema di Claudio Caligari”, Fausto Trombetta, è radicato nel tempo. Lei non ha solamente composto le musiche del suo precedente documentario, “Sotto la sabbia”, ma entrambi avete un legame speciale con il primo film di Caligari, “Amore Tossico”, visto che Michela Mioni è sua zia acquisita e Trombetta è invece il nipote dell’interprete del “pappone”. È stato complesso mantenere un equilibrio nel racconto tra le tappe lavorative e la storia privata e intima di Caligari?
No, perché le “tappe lavorative” di Claudio come è noto sono state purtroppo pochissime, solo tre film in trent’anni, ma la sua vita è stata ugualmente tutta imperniata su questo: un’infinita lotta, contro i meccanismi produttivi, la censura, i finanziamenti, e infine una lotta anche contro sé stesso, contro la propria malattia e contro il tempo.
Fausto è il primo a cui ho proposto la regìa del progetto proprio perché avevamo una conoscenza condivisa della materia: sapevamo di prenderci una grossa responsabilità, ma sapevamo anche che toccava a noi perché nessun altro avrebbe potuto farlo nello stesso modo. Quando siamo arrivati a Simone Isola inizialmente era un testimone da intervistare alla stregua degli altri, in qualità di produttore di “Non essere cattivo”, poi invece lui si è innamorato subito del progetto e ci ha proposto di unire le forze, diventando co-regista. Inizialmente noi avevamo una visione più sbilanciata su “Amore tossico”, perché venivamo da quell’ambiente, e Simone una più sbilanciata su “Non essere cattivo”, perché pur non facendo parte di quel mondo aveva però fatto parte di quel film: credo che ogni punto di vista da solo sarebbe stato parziale, Fausto e Simone hanno avuto l’intelligenza di capire che unire le forze in nome di un ideale più alto era la cosa giusta da fare; e li ringrazio per questo, perché tutto è avvenuto così spontaneamente che solo oggi mi rendo conto che invece non era affatto scontato: probabilmente molti altri al posto loro avrebbero preferito fare un lavoro meno ambizioso, magari meno completo, ma farselo da soli senza dover mettere in discussione alcuna scelta con gli altri.
Oltre ad essere l’ideatore dell’omaggio a Caligari, è anche il curatore della colonna sonora. Che sonorità ha preferito utilizzare nel documentario?
Ho lavorato molto con vibrato e tremolo, sia sulle chitarre che sul piano elettrico. Ricordo che Paolo Vivaldi, l’autore delle musiche di “Non essere cattivo” era seduto accanto a me alla prima di Venezia e alla fine mi disse “bravo, a un certo punto non capivo più quali musiche erano mie e quali tue!”, che da un compositore di quel livello credo sia il complimento più grande che si possa ricevere. Ma in realtà ho pensato solo alle atmosfere dei suoi film e a come li avrei musicati io se avessi avuto quel compito: nei film di Claudio i temi portanti hanno sempre avuto la voce di sassofoni o trombe, una cosa di cui sono orgoglioso è di aver sostituito quei fiati con l’armonica a bocca, che è uno strumento che si sposa benissimo con il rumore di fondo del vento e del mare e che evoca sempre scenari epici, da western: in fondo Se c’è un aldilà sono fottuto è un titolo epico.
Lei è stato presente durante le riprese dell’ultimo film di Caligari, “Non essere cattivo”. Dal documentario si percepisce un pudico ma potentissimo affetto di tutta la troupe e attori nei confronti di questo talentuoso, coraggioso e perciò scomodo regista. Come ha vissuto quei giorni particolari sul set?
Sono andato sul set spesso, ma solo perché la voglia di conoscere Claudio ha avuto la meglio sulla mia discrezione e mi ci auto-invitavo sfacciatamente. Perfino zia Michela (Mioni, ndr.), che non lo aveva più incontrato dopo “Amore tossico”, dopo 30 anni non era sicura che avrebbe avuto voglia di rivederla: invece si abbracciarono subito e passarono tutto il resto della giornata insieme. Io rimasi sempre in disparte sinceramente, mi bastava osservarlo al lavoro; ma ti confermo che questo “pudore” nei suoi confronti lo mostravano tutti, pensavano solo a servirlo al meglio nella realizzazione di ciò che voleva.

Lei è nato e cresciuto ad Ostia, città che oramai, nell’immaginario collettivo, si presenta come terra di degrado e silenzi. È proprio ad Ostia che non solamente ha girato il videoclip di accompagnamento al suo omaggio musicale a Pasolini, “Sotto lo stesso cielo”, ma ha animato la sua antologia di poesie “Ostia! Romanzo di una periferia”. Che rapporto ha oggi con la sua città?
È vero, Ostia è l’unica periferia di Roma che viene definita “città” e non “quartiere”. Nel corso degli anni mi sono chiesto spesso perché uno venuto da fuori come Caligari avesse scelto proprio Ostia per ambientarvi le sue storie. E ancora una volta mi sono riposto da musicista: alcuni dicono che la vera essenza del blues si trovi nel Delta del Mississippi perché alla foce di un fiume si condensano tutte le storie che il fiume raccoglie durante il suo corso: forse questo vale anche per la foce del Tevere, forse l’immagine della vera Roma che Claudio aveva in mente gli appariva più chiaramente qui, a Ostia, proprio dove tutto finisce; ed è lo stesso motivo per cui alla fine ci torno sempre anch’io.

Il suo primo album da solista, “Jukebox all’Idroscalo”, è un graffiante e dissacrante tripudio ironico di citazioni, da Dario Argento a De André. Come mai lei sceglie di rappresentare spesso personaggi al limite, dissidenti di quella che viene definita “la normalità”?
Forse la mia normalità è questa, non sono nemmeno sicuro che “la normalità” esista. Credo che l’unico requisito fondamentale di un cantautore oggi sia la credibilità. Mettere sullo stesso piano riferimenti diversi (come la nouvelle vague o la new wave, che poi letteralmente significano la stessa cosa) è tipico del post-moderno, scomodare santini intoccabili come De André è tipico di quell’ironia provocatoria che lui stesso ci ha insegnato. Per questo poi il disco si intitola “Jukebox all’Idroscalo”, un gioco di parole fra “Jukebox all’Idrogeno” (il libro di poesie di Ginsberg) e il luogo della morte di Pasolini: da una parte la “rivelazione” della psichedelia, dall’altra il “mistero” italiano par exellence, c’è il legame con la beat generation ma anche la consapevolezza di far parte di una periferia, di un mondo marginale in senso non solo geografico ma anche culturale.

Se dovesse paragonare Claudio Caligari a uno strumento musicale quale sarebbe?
Sarebbe uno strumento del tutto autosufficiente ma in grado di guidare anche un gruppo, lo strumento più completo, più versatile, con lo spettro di registri più ampio di tutti: quindi sicuramente il pianoforte.
Per guardare il docu-film “Se c’è un’ aldilà sono fottuto – Vita e Cinema di Claudio Caligari“ sul sito di RaiPlay cliccate Qui.
(Copyright immagine in evidenza)
Categorie:MetisMagazine